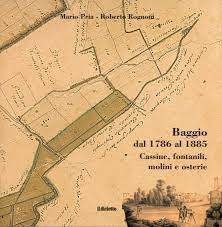Il Lambro (Lamber o Lambar ) è un fiume della Lombardia lungo 130 km, tributario di sinistra del Po.
Il colatore Lambro Meridionale, che si forma a Milano e raccoglie anche parte delle acque dell'Olona, è il suo maggiore affluente.
Il nome italiano del fiume deriva dal latino Lambrus, che deriva a sua volta da un antico lemma gallico, costruito da "lam", "palude".
Di molto meno plausibile, e frutto dell'amore per l'antichità classica che è retaggio dell'afflato nazionalistico italico, appare l'idea di ascrivere l'etimologia al greco λαμπρως (lampròs) 'lucente', come la sua acqua. D'altronde le fonti classiche denotano come il Lambro nascesse sui monti occupati dai Celtoliguri (si veda al proposito Sidonio Apollinare, vescovo Gallo-romano del quinto secolo), e non appare che costoro fossero ellenofoni.
A detrimento della teoria del nome greco, si può osservare che Antonio de Beatis, segretario del cardinale Luigi d'Aragona, che accompagnò in un lungo viaggio in Europa, nel suo Diario di viaggio, descrive il Lambro in questo modo: "giunti al Lambro nei pressi di Monza, questo era fangosissimo, in antitesi con il suo nome".
Il fiume nasce dai monti del gruppo del San Primo (Triangolo lariano), a 944 metri, nell'area di Piano Rancio nel comune di Magreglio poco a nord del Ghisallo. La sorgente del Lambro è di tipo carsico e viene chiamata Menaresta perché "mena" cioè "va, porta" e "resta" cioè "rimane"; infatti un serbatoio a sifone sotterraneo, posto nella roccia calcarea, si riempie d'acqua a intervalli regolari, fino a traboccare con un flusso vivace per poi rallentarlo prima di caricarsi nuovamente; l'intero ciclo dura otto minuti. Dalla Menaresta un ruscelletto scorre quindi verso Magreglio.
Il fiume, che riceve il suo primo affluente (il Lambretto) a Lasnigo (le cui sorgenti sono nella conca di Crezzo), attraversa con corso rapido la Valassina, bagnando i centri di Asso, Canzo, Ponte Lambro ed Erba. A Erba si immette nel lago di Pusiano.
Il termine "Lambrone" (Lambron in dialetto milanese) è il nome dato storicamente alla deviazione del fiume Lambro, fatta nel XIX secolo, per farlo sfociare nel lago di Pusiano. Questa deviazione, insieme a una diga chiamata Cavo Diotti, oggi ancora funzionante, risulta fondamentale nella regolazione del livello delle acque del medio corso del Lambro, salvando le città (Monza in primis) a valle. Il Cavo Diotti è la diga che regola il flusso in uscita dall'ampio bacino del lago di Pusiano (12.750 milioni di metri cubi). A causa delle dimensioni del bacino, la diga (composta da 2 paratie alte circa 70 cm) è classificata di importanza nazionale. La gestione del flusso delle acque è affidata al Consorzio del Parco regionale della Valle del Lambro.
Uscito dal lago il fiume riceve da destra l'emissario del lago di Alserio dopodiché bagna il centro di Merone. Da qui scorre con andamento tortuoso ai piedi delle colline moreniche (dove raccoglie le acque di svariati rii, rogge e di laghetti brianzoli) raggiungendo poi la città di Monza.
Subito dopo attraversa l'omonimo parco dividendosi poi, nei pressi della Chiesa del Carrobiolo in due rami: il Lambro, che passa sotto il Ponte dei Leoni, ed il Lambretto che fu fatto deviare nel XIV secolo dai Visconti per la difesa della città. Dalla sorgente nel gruppo montuoso di San Primo al Viale Cavriga nel Parco di Monza, il Lambro è il fiume della Brianza.
Uscito da Monza nuovamente con corso riunito, il fiume attraversa Brugherio, Sesto San Giovanni e Cologno Monzese (Parco Media Valle del Lambro), per poi scorrere sotto il ponte-canale del Naviglio della Martesana ricevendone le eventuali acque in eccesso ed entra a Milano di cui percorre, da nord a sud, tutta la periferia orientale. È il maggiore dei tre fiumi milanesi ed è l'unico a scorrere, per la maggior parte del tratto cittadino, a cielo aperto. Attraversa i quartieri di Cascina Gobba, Cimiano, parco Lambro, Lambrate, Ortica-parco Forlanini, Ponte Lambro e Monluè.
Riceve la roggia Lirone, emissario dell'Idroscalo e alcune altre minori provenienti dall'est-Milano. Cimiano, Ortica e Lambrate furono accorpate al capoluogo nel 1923. Dal 2010 il comune di Milano sta compiendo lavori per la continuità dei tre parchi cittadini lungo il percorso del fiume e l'intera area rientra in quella, più estesa, del Parco sud. A Lambrate era presente lo stabilimento meccanico della Innocenti, che nel dopoguerra lanciò uno scooter che ebbe grande successo commerciale in tutto il mondo con il marchio Lambretta, nome ispirato al fiume.
Uscendo da Milano, a Peschiera Borromeo, il Lambro riceve le acque trattate dal depuratore Milano-est, a monte di Melegnano quelle del colatore Addetta che ne accrescono artificialmente la portata e, giunto a Melegnano, quelle del Cavo Redefossi, arricchite più a monte dalla Vettabbia, entrando poi alcuni chilometri a valle in provincia di Lodi.
Con corso più lento il fiume attraversa in seguito la cittadina di Sant'Angelo Lodigiano ricevendo da destra il Lambro meridionale. Con portata quasi raddoppiata il fiume prosegue lento bagnando il centro di San Colombano al Lambro, fungendo anche per un brevissimo tratto da confine fra le province di Lodi e Pavia, e una volta giunto a Orio Litta confluisce da sinistra nel Po. Il Consorzio del Basso Lambro raggruppa i 27 comuni interessati dall'ultimo tratto del fiume: qui non esiste una rete di collettamento delle acque unificata, ma ogni comune è dotato di depuratore e l'uso irriguo delle acque è ancora (2010) fortemente problematico.
Il fiume Lambro conta 27 affluenti, per lo più naturali ma di scarsa rilevanza quelli nella parte settentrionale del corso fino a Monza, più copiosi ma artificiali quelli da Milano alla foce nel Po, anche se scavati, come la Vettabbia, addirittura in epoca romana. Una modesta quantità d'acqua (1,2 m³/s) proviene direttamente dal depuratore Milano-est.
Anche più a monte, a Merone prima e a Brugherio dove è situato l'impianto di Monza San Rocco successivamente ,il Lambro riceve le acque trattate dai due depuratori che di fatto, in condizioni di tempo asciutto, ne rappresentano i due principali immissari dell'alto e medio corso.
Elenco degli affluenti:
- Ruscà
- Foce [Pusallo]
- Sancio [Scet]
- Ravella
- Vallelunga
- Bova—Il Lambro si immette nel Lago di Pusiano col nome di Lambrone --
- Il lago di Pusiano è alimentato dall'emissario del Segrino—Il Lambro esce dal Lago di Pusiano --
- Cavo Diotti (altro emissario del Lago di Pusiano)
- Emissario di Alserio [Lago di Alserio]
- Roggia Gallarana
- Roggia Ghiringhella
- Bevera di Molteno [Gandaloglio, Beveretta]
- Cavolto
- Bevera di Nibionno
- Bevera di Renate
- Brovada (affluente di sinistra in prossimità di Triuggio)
- Cantalupo
- Pegorino
- Molgorana
- Roggia Spazzola
- Roggia Lirone [Idroscalo di Milano]
- Colatore Addetta
- Cavo Redefossi (Naviglio della Martesana, Seveso, Molia), Vettabbia, Cavo Taverna, Fontanile di Macconago, La Fogna]
- Scaricatore Sillaro
- Colatore Lissone
- Colatore Lambro Meridionale, derivato a Milano dal Naviglio Grande e principale tributario del fiume (portata 2,6 m3/s) che a Milano a San Cristoforo riceve la parte delle acque dell'Olona, e del suo bacino idrografico, che non sono state deviate nel Canale Scolmatore di Nord Ovest o nel deviatore Olona, oltre che del Cavo Ticinello, della Roggia Pizzabrosa e della Roggia Taverna.
- Cavo Sillaro [Roggia Fratta, Roggia Sillarina]
- Scaricatore Venere
Fu Carlo Amoretti a descrivere per primo il curioso comportamento intercalante della sorgente del Lambro nel suo Viaggio da Milano ai Tre Laghi del 1791, descrivendo il fenomeno e la zona carsica circostante. Alcune incisioni rupestri non figurative, scoperte il secolo scorso, fanno risalire i primi insediamenti umani, che praticavano probabilmente il culto delle pietre, nell'area della sorgente al III-I millennio prima di Cristo. Il fiume discende rapido fino ai 320 metri del Piano d'Erba e qui, il brusco cambio di pendenza e il rallentamento della velocità dell'acqua hanno provocato danni e alluvioni fino dall'antichità per il frequente accumulo di detriti.
Le acque ostacolate nel loro naturale deflusso raggiungevano il lago di Pusiano in mille rivoli, spesso impaludandosi, e nel 1799 il fiume perse definitivamente l'alveo originario. Fu soltanto nel 1817, durante il dominio austriaco, che ne venne scavato uno artificiale, il Lambrone, sufficientemente largo e rettilineo per recapitare il fiume sino alla sua nuova foce nel lago nei pressi di Pusiano. Col suo apporto, il Lambro avrebbe tra l'altro dovuto innescarne il deflusso mantenendone il livello più alto. Nel corso naturale, il fiume passava tra questo lago a est e quello di Alserio a ovest, ricevendone entrambi gli emissari dove oggi è situato Pontenuovo di Merone: in periodi di secca le acque rigurgitavano nel primo senza defluire a valle e con le piene spesso i due laghi si congiungevano ridando vita al lago Eupilio descritto da Plinio il Vecchio.
Prima che la forza motrice delle acque del Lambro diventasse l'asse principale della protoindustrializzazione briantea, il lago di Pusiano fu già destinato a regolarne il flusso. A beneficiare dell'irrigazione erano soprattutto i fondi della basilica di San Giovanni Battista a Monza: i canonici imposero la costruzione della marmorea "soglia di San Giovanni", uno sfioratore mobile che controllava con precisione la quantità d'acqua rilasciate dal lago.
Pur di modesta profondità, il lago di Pusiano, anche nei periodi di secca, era comunque un serbatoio d'acqua dalle considerevoli potenzialità e fu così che un possidente e uomo d'affari milanese, l'avvocato Luigi Diotti, pensò di sfruttare la risorsa. Un affare molto simile gli era riuscito qualche anno prima per il Cavo Diotti (omonimo con la sopracitata diga sul lago di Pusiano), che interessava invece il fiume Olona. Si trattava di dare al lago un emissario a livello inferiore, scavandone uno artificiale con un breve tratto sotterraneo che sfociasse a una quota più bassa. Si accordò nel 1793 con il proprietario del lago, il marchese Antonio Mollo, con l'intesa sul carico delle spese e su una spartizione alla pari degli utili.
In quel periodo, ai numerosi mulini, lungo la valle, da Merone fino a Monza, si erano aggiunti vari nuovi opifici e un flusso regolare del fiume era ancora più necessario, così vennero avanzate le richieste per l'autorizzazione dei lavori, ma non erano tempi politicamente facili: la sovranità sulla Lombardia passò dall'Austria alla Francia nel maggio 1796, tornò brevemente agli Austriaci il 28 aprile 1799, ma il 2 giugno 1800 fu di nuovo francese: ogni volta che le pratiche autorizzative dell'opera sembravano compiute, si dovevano ricominciare presso una nuova autorità.
A complicare le cose, nel 1805 il marchese Mollo vendette il lago al marchese Gerolamo D'Adda, seppure con l'obbligo del rispetto dei patti a suo tempo sottoscritti col Diotti. Milano era diventata la capitale del Regno d'Italia ed Eugenio di Beauharnais era il Viceré e nel 1809 approvò il progetto; risiedeva spesso nella Villa Reale di Monza e ne voleva abbellire il parco e i diritti d'acqua del fiume non erano secondari. Nel 1811 il lago viene acquistato dal Monte Napoleone (la banca che gestiva il debito pubblico del regno) e dato in appannaggio al principe, mentre i non complicati lavori venivano compiuti, per un costo complessivo di 100.000 lire. Il 26 aprile 1814 il principe abdica e abbandona l'Italia e il nuovo governo del lombardo-veneto sceglierà per il Lambro la costruzione del Lambrone, che diventa operativo nel 1817.
Nel 1831 il governo decide la vendita del lago di Pusiano che viene acquistato da due ricchi banchieri, i fratelli Marietti. Questi nel 1834 decidono autonomamente, avendo la piena disponibilità dell'acqua, di aprire la chiusa e convogliarla a valle, provocando un'alluvione; così le prese sono murate d'autorità e l'acqua che sarebbe così utile resta nel bacino. Alla metà del secolo, dal Pontenuovo al Naviglio della Martesana si contano 57 opifici industriali, tra i quali sei setifici, cinque filature di cotone, due manifatture di cappelli e due cartiere, ma l'acqua, nei periodi estivi in particolare, continua a scarseggiare.
A Vedano, è titolare di uno dei cotonifici Giulio Fumagalli: è convinto che al lago di Pusiano si potrà attingere solo una volta diventatine i proprietari e si fa promotore di un consorzio tra gli utenti (1876) che raggiungerà lo scopo l'anno successivo acquistandolo dal comune di Pusiano per 224.000 lire. Il consorzio, diventato società, gestirà, con grandi vantaggi dei soci e del Lambro finalmente regolarizzato, il lago e il Cavo Diotti fino al 1922, anno in cui le relative acque diventano pubbliche. All'epoca, la forza motrice dell'acqua viene sostituita dall'energia elettrica, ma il cavo ha continuato a funzionare da regolatore del fiume sino ai giorni nostri.
Nello scorcio del secolo scorso, per l'alta urbanizzazione della valle e la conseguente impermeabilizzazione dei suoli, la natura del rischio è mutata e ora è forte quello da inondazione. Dopo quella disastrosa del 2002 fu deciso che lago di Pusiano e Cavo Diotti dovessero rafforzare il loro ruolo di regolatori delle acque.
La proprietà è ora del demanio regionale e la gestione è affidata al parco regionale della Valle del Lambro e i lavori di ammodernamento si sono completati nell'ottobre del 2012. La storia del fiume si è intanto arricchita di un nuovo e per alcuni aspetti curioso capitolo: l'impianto il cui invaso (il lago stesso) supera il milione di metri cubi ha dovuto essere iscritto nel RID, il Registro Italiano Dighe e questo malgrado le paratoie che regolano lo scorrere dell'acqua siano soltanto due robuste tavole di rovere che non raggiungono, assieme, i quattro metri quadrati. Così il complesso sarà dotato dei più moderni strumenti di monitoraggio e sorveglianza e di personale altamente qualificato a tutto vantaggio dei cittadini rivieraschi.




 copertura del grande Sevese in via Larga
copertura del grande Sevese in via Larga