LA STORIA DELLA FONTANA RACCONTATA DIRETTAMENTE DAL PROGETTISTA
Renzo Gerla fu un architetto del Comune di Milano, che fece grandi opere e ristrutturazioni dagli anni 20 fino agli anni 60 del secolo scorso. Una dei primi progetti fu appunto la fontana delle Quattro Stagioni, ubicata in piazza Giulio Cesare. La storia, decisamente avventurosa, di questa fontana la narra lui stesso sulla Martinella di Milano, rivista fondata nel 1947 da Emilio Guicciardi.
Febbraio 1927: quasi a ridosso dell’apertura della Fiera Campionaria di Milano e durante i lavori della nuova porta di accesso in piazza Giulio Cesare, Renzo Gerla, chiamato dal podestà Ernesto Belloni, alla richiesta di costruire una fontana nella depressione del piazzale, che si riempiva d’acqua durante i temporali, propose uno schizzo in visione prospettica su carta assorbente della fontana che tutti conosciamo.
Ma doveva essere pronta per la mattina del 12 aprile e quindi non si poteva perdere neanche un minuto. Redatto il progetto, andava cercata la ditta in grado di svolgere in cosi breve tempo la costruzione, che risultò essere la Franco Pelitti e figlio, che già aveva lavorato per la Galleria Vittorio Emanuele e che il Gerla conosceva da tempo e di cui conosceva la professionalità. La ditta si prese solo 24 ore per rispondere e propose la pietra di Sarnico, invece del Ceppo, causa inagibilità delle cave per le abbondanti nevicate invernali.
Tra i disegni da fare in ufficio, le corse alla cava dei Fratelli Cadei a Sarnico sul lago di Iseo (ditta ancora esistente) e i sopralluoghi di giorno e di notte al cantiere perché si lavorava ininterrottamente a turni alla luce delle lampade elettriche non c’era un attimo di respiro. Anche con la nebbia, perché la nebbia allora era ovunque specialmente d’inverno e di notte.
Già all’inizio, con grande lungimiranza, gli impianti idraulici erano a ricircolo delle acque, che venivano predisposti in contemporanea con l’illuminazione e i giochi d’acqua da un duo di ingegneri, Giovanni Trosti e Camillo Borioli, di comprovata esperienza, come sottolinea Renzo Gerla nel suo articolo. Il ricircolo delle acque venne poi abbandonato e solo con la ristrutturazione effettuata a spese di City Life si è tornati al ricircolo delle acque.
Nell’ultima settimana, prima dell’inaugurazione della Fiera era quasi tutto pronto, ma mancava una parte fondamentale, ossia le statue delle quattro stagioni, che davano la caratterizzazione alla fontana stessa. Chi aveva promesso di fornirle, ossia il professor Piero Portaluppi, insigne architetto milanese, non potè procedere causa impossibilità di utilizzare le statue pattuite.
Renzo Gerla parla della sorpresa e dell’amarezza di non avere le statue pattuite e soprattutto di non sapere proprio cosa fare. All’ultimo momento decise di andare a Vicenza, patria, in quei tempi soprattutto, di scultori e “marmorari” per poter acquistare quattro statue in pietra vicentina. Il permesso di procedere arrivò la mattina dell’11 aprile, appena il giorno prima l’apertura ufficiale della Fiera Campionaria e nel pomeriggio partì verso Vicenza.
La disperata ricerca, in un primo momento, risultò infruttuosa. Solo dopo mezzanotte e dopo frenetiche telefonate con la ditta Pelitti, vennero scelte a lume di candela e comprate le statue, molto belle, da un professore di scultura. Dopo la contrattazione sul prezzo- vennero pagate 1000 lire l’una– bisognava caricare la merce sul camion ed il problema sembrava insolubile, soprattutto per l’ora tarda.
Ma, previdente, il Gerla aveva una lettera credenziale del Comune di Milano che portò al Comune di Vicenza, dove, per una insperata fortuna, era in corso, di notte, il Consiglio Comunale ed il cui Presidente risolse il problema, mandando una squadra equipaggiata dei vigili del fuoco.
“Bianca la notte, bianca la luna, bianche le quattro statue stivate per traverso sul largo camion e la certezza di avere la soluzione ed il trionfo”.
Alle 7 del 12 aprile arrivo in piazza Giulio Cesare, alle 8 le statue posizionate, nonostante qualche piccolo intoppo tecnico.
Già l’anno dopo l’Estate venne distrutta da una bomba posizionata a pochi metri di distanza, che costò la vita a 16 persone e nel 1943 le bombe inglesi fecero il resto.
Solo nel 1953 furono commissionate e rifatte le statue distrutte, incaricando lo scultore Eros Pellini, che le rifece in pietra di Vicenza e le cui copie si ritrovano al museo di Marchirolo, a lui dedicato.
A chiusura della sua cronaca il Gerla si rammarica che manca la parte dedicata alla musica, perché con i giochi d’acqua sarebbe bello ascoltare le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi, magari tramite un organo idraulico.


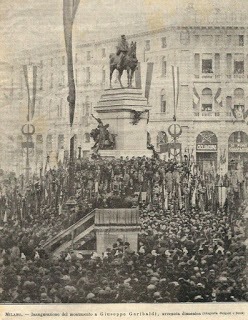


















 Per la realizzazione furono necessari tredici anni, durante i quali lo scultore apportò alcune modifiche (semplificando l'obelisco come indicato dalla commissione).
Per la realizzazione furono necessari tredici anni, durante i quali lo scultore apportò alcune modifiche (semplificando l'obelisco come indicato dalla commissione).








