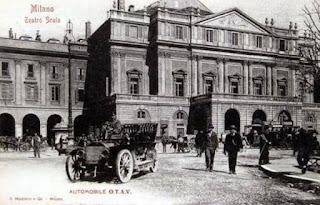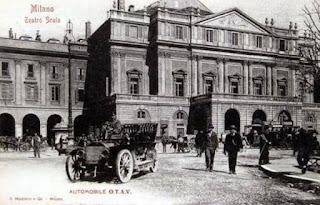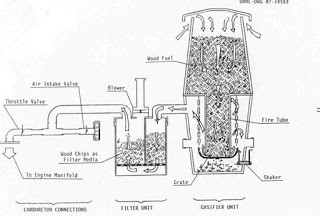Da quando, il 2 novembre 1893, vennero introdotti i tram elettrici, Milano ha visto correre (si fa per dire) molti modelli di vetture tranviarie. Alcuni tram ebbero grande fortuna, altri circolarono in poche unità e per pochi anni. Vediamo i vari modelli in ordine cronologico di costruzione (che non coincide necessariamente con l'ordine numerico delle serie).
Sono tralasciate alcune serie del tutto sperimentali o quasi, non avendo tali vetture mai prestato effettivo servizio all'utenza oppure solo saltuariamente per pochi mesi.
Ricordiamo inoltre che numerose furono le vetture tranviarie speciali, adattate cioè a vari compiti cittadini (ad esempio: tram spazzaneve, tram ambulanza durante la I guerra mondiale, tram funebre, tram lavastrade, ecc.).
Serie Edison
Per il servizio tranviario elettrico introdotto nel 1893 dalla Edison vennero utilizzate piccole vetture bidirezionali a due assi, con telaio metallico e cassa di legno, caratterizzate da terrazzini aperti alle estremità.
Furono, durante gli anni, costruite da più industrie: Breda, Carminati e Toselli, OM, Miani e Silvestri... Il motore era a corrente continua 600 V, la capacità di 36 passeggeri. Colore: rosso con filettature nere; poi dal 1900 muterà in nero-giallo-bianco Vennero poi rese unidirezionali e trasformate, senza motore, in rimorchi per aumentare le capacità di carico: era usuale un tempoi vedere circolare tram con rimorchio.
Ne è esistita anche una versione a due piani per la Milano-Monza. Serie 600 e 700
Passato il servizio tramviario, nel 1917, in mano al Comune per il tramite di ATM, le Edison vennero affiancate poco dopo la prima guerra mondiale dalla serie 600, vettura a due assi bidirezionali. Fu costruita tra il 1924 e il 1928, ed ebbe un'attività di servizio molto lunga.
La costruzione fu affidata a diverse industrie: Carminati e Toselli, Breda, OM. Per i motori elettrici: Compagnia Generale Elettricità e Tecnomasio Italiana Brown Boveri.
Questi tram subirono nei decenni varie modifiche, furono anche sfruttati per costruire serie articolate successive. Le 600 andate gravemente danneggiate durante i bombardamenti angloamericani furono negli anni successivi ricostruite dalla Caproni (a Taliedo) e classificate come serie 700 (attualmente ne sopravvivono alcuni esemplari).
Oggi circola anche una 600 storica, ma in realtà si tratta di una 700 riattata. Serie 1500 (dette Ventotto o Carrelli o Peter Witt)
L'ATM fece costruire, tra il 1928 e il 1930, 500 unità di questo innovativo modello, per rinnovare il parco tranviario milanese ancora legato a piccole vetture a due assi. La costruzione fu opera di più industrie, tra le quali principalmente Carminati e Toselli, Breda, OM.
L'idea della cassa con carrelli a due assi indipendenti dal corpo vettura venne mutuata dal progetto americano di Peter Witt (ingegnere e politico di Cleveland): questo modello permetteva di far circolare tram con una cassa molto più lunga dei modelli fino ad allora realizzati.
Originariamente a due porte, e con salottino fumatori in coda alla vettura.
A parte i primissimi esemplari di colore giallo crema, tutte le vetture vennero consegnate in colorazione bitonale verde, rimasta in uso fino algli anni sessanta, quando fu sostituita con la livrea arancione.
Nati con il trolley per la prese di corrente aerea, negli anni settanta vennero modificati per circolare con il pantografo.
A Milano circolano tutt'ora per servizi regolari di trasporto passeggeri (mentre in altre città circolano su linee turistiche o come vetture storiche per occasioni particolari). Serie 3000 (detta scherzosamente "due camere e cucina")
Realizzata dalle Officine ATM di Teodosio nel 1932-1934 questa serie articolata era costituita da due vetture rimorchio accoppiate e dotate di motore prelevato dalla Edison in fase di dismissione, con al centro una cassa sospesa collegata tramite mantici di intercomunicazione fornita dalla Carminati e Toselli.
Quasi tutte distrutte durante i bombardamenti angloamericani, ne sopravvissero pochi esemplari, mentre altre vetture furono sfruttate per costruire la serie 4000.
Serie 4000 e 4100
Evoluzioni della serie 3000 realizzate sempre in proprio da ATM, esteticamente molto simili. Serie 5000
Dalla metà degli anni trenta ATM cominciò gli studi per una nuova vettura tramviaria: nacque la serie 5000, realizzata quasi interamente con profilati in leghe d'alluminio, tenuti insieme da bulloni; la struttura portante, di tipo reticolare, presentava un rivestimento esterno in lamierino d'alluminio, a sua volta incollato su pannelli di legno compensato.
Le casse furono realizzate da tre fornitori: Breda , Officine Elettroferroviarie Tallero e Officine Meccaniche, tra il 1936 e il 1939. I carrelli vennero forniti dalla TIBB, e l'equipaggiamento elettrico dalla Marelli.
Le poche 5000 sopravvissute ai bombardamenti prestarono servizio per altri tre decenni. Serie 4500
Piccola serie di vetture articolate a due casse, costruite dal 1942 al 1944 dall'Officina Meccanica della Stanga, articolando le vetture 5000.
Il meccanismo di articolazione centrale era di tipo innovativo, e conosciuto con il termine di "giostra urbinati". Le vetture 5100 erano motrici a carrelli ricavate dalla ricostruzione delle serie 5000 danneggiate durante la guerra, elaborate dall'Ansaldo di Genova alla fine degli anni quaranta (1947-1951).
Ne sopravvivono alcune unità.
Le 5200 erano vetture consegnate a partire dal 1952, e differivano per alcuni particolari elettrici ed interni dalle 5100. Le 5300 furono l'evoluzione delle 5200. Le vetture 4600 vennero progettate come versione articolata a due casse della serie 5300.
tram milanoI primi esemplari furono consegnate dalla Stanga di Padova a partire dal 1955, ma altre unità entrarono in servizio negli anni sessanta, realizzate dalla Breda. Tram articolato a tre casse, ideato come prototipo nel 1971 da ATM Teodosio (poi costruito in serie da Mauri negli anni successivi) sfruttando le vetture 5200 e 5300: queste erano unite ad una cassa centrale costruita ex novo.
Le ultime unità cessarono l'esercizio il 31 dicembre 2010. Serie costituita da sole tre vetture (dette bassotte) acquistate usate dall'ATAC di Roma, circolarono a Milano tra il 1951 e il 1966. Tram a tre casse (tutt'ora in circolazione regolarmente) realizzati da Fiat e Stanga tra il 1976 e il 1978 (e modificate nella coda tra il 1982 e il 1984). Motori TIBB e AEG.
Recentemente alcune vetture sono state rimodernate nella livrea e nella impiantistica. Tram di recente costruzione (a partire dal 2000), in circolazione sulle linee di forza dirette in periferia. Conosciuti come Eurotram, Sirio e Sirietto.