Il Cotonificio Cederna è stato uno stabilimento tessile molto importante per la città di Milano. Il sito produttivo è stato fondato da Antonio Cederna nel 1886 nella zona sud della città, a Gratosoglio. Nel 2000 è stato venduto dalla famiglia Cederna a TMR che ha assunto il nome di “TMR-Cederna fodere”, mantenendo soltanto la tintoria dei tessuti a Gratosoglio. A Febbraio 2020 l’unità di Gratosoglio è stata chiusa definitivamente. Lo stabilimento storico si estende per circa 30 mila m² sulle sponde del Lambro Meridionale, zona molto ricca d’acqua, sia per il fiume che per le falde, ideali per la produzione di tessuti e per la tintoria. Ci si arriva percorrendo la via Gratosoglio, laddove agli inizi del Novecento scorreva il fiume Lambro, prima della deviazione. Il Cotonificio esisteva già a metà Ottocento ed era in legno, più tardi venne edificato, come si vede ancora oggi. È composto dall’edificio dell’ex asilo nido Regina Margherita sulla via Gratosoglio, poi diventato alloggio dei dirigenti; da una villetta d’inizio Novecento, che è stata la sede dei vigili per alcuni anni; da un caseggiato per l’alloggio dei dipendenti; e dallo stabilimento vero e proprio. Quando non esistevano ancora i quartieri popolari e residenziali visibili oggi, nella zona sorgevano l’antico borgo di Gratosoglio, i campi coltivati, la Cartiera di Verona, la Cartiera Binda e la riseria Gariboldi, tutti grandi stabilimenti che diedero lavoro a centinaia e centinaia di dipendenti e che offrivano loro tutti i servizi necessari. Il Cotonificio Cederna aveva le case per i dipendenti, l’asilo gestito dalle suore, l’infermeria, la mensa, la bocciofila per la ricreazione dei dipendenti e le colonie per i loro figli. C’era anche la Chiesa, in questo caso la nuova Chiesa di San Barnaba in Gratosoglio, costruita negli anni Quaranta, vide la partecipazione dei Cederna al progetto ed all’edificazione. Il Cotonificio ha attraversato un secolo complesso fatto di innovazioni e nuove sfide per giungere fino al febbraio 2020. Negli anni Settanta la produzione contava circa 200 dipendenti, negli anni Novanta 120, negli ultimi anni 28. Lo stabilimento produceva inizialmente stoffe e fodere per vestiti e abiti classici e tingeva i tessuti. Negli anni 80-90 produceva soprattutto in Italia, fornendo i grossi gruppi tessili come Lebole, Gruppo finanziario tessile, Marzotto, Canali… Negli anni il mercato tessile è cambiato e l’azienda ha cercato di adattarsi, iniziando a produrre anche tessuti tecnici – sportivi. L’adattamento ha generato grossi problemi finanziari ed economici ed ha portato alla vendita delle azioni a TMR. Il responsabile di stabilimento fino al febbraio 2020 e Luigi Sforza, responsabile di stabilimento e, precedentemente, responsabile dell’Officina, ora in pensione. La fabbrica, uno spazio molto, molto vasto, silente, con gli ultimi macchinari visibili, le aree dedicate alla produzione delle fodere, le aree per la tintoria, per le analisi chimico-fisiche di laboratorio, uno spazio esterno per la depurazione delle acque, che venivano convogliate al depuratore del Ronchetto, uno per i controlli della qualità del prodotto, un reparto separato da un cancello dove lavoravano le donne specializzate nel confezionamento, gli spogliatoi, la mensa, gli uffici.
Ivano ha lavorato 30 anni al Cotonificio. Gran parte della sua famiglia ha lavorato lì. Suo padre ci aveva lavorato dal 1950 al 1984 come operaio, poi anche i suoi zii e le sue zie. Dopo il militare, nel 1986, ha iniziato a lavorare. Negli anni è passato da quasi tutti i reparti fino a diventare responsabile di stabilimento.
Cederna cercò di creare un luogo di lavoro il più possibile familiare e collaborativo. Negli ultimi anni i rapporti di lavorativi, con l’evoluzione del mondo del lavoro, erano cambiati molto.
Dapprima era stata un punto di riferimento lavorativo e aggregativo, poi, negli anni Novanta, con il sorgere degli ultimi quartieri costruiti nelle vicinanze, era diventata un peso. Tante erano state le segnalazioni per i rumori, per i fumi, per gli odori, augurandosi che portassero alla chiusura del sito.
Luigi ha lavorato alla Cederna dal 1973 al 2002. Iniziò perché ci lavoravano il suocero e due suoi zii, partendo come garzone in officina, saldatore idraulico. Poco dopo sono iniziati i primi cambiamenti. Nel 1977 alcuni operai della precedente generazione sono andati in pensione, sono arrivate persone nuove, come anche il responsabile dell’officina, il signor Diorio che arrivava dalla Bassetti. S’iniziò a cambiare la modalità tecnica ed organizzativa del lavoro.
Diorio era responsabile tecnico nei quattro stabilimenti (Gratosoglio, Monza, Agrate, Trento). Luigi diventò capo officina.
L’azienda fu ristrutturata, i signori TMR investirono su nuovi macchinari che sostituirono i vecchi più specializzati nella lavorazione del cotone. Nel 2002 Luigi è andato in pensione, restando come memoria storica dell’azienda. Dopo dieci anni di consulenze ha lasciato l’incarico per poi rientrare per supervisionare i settori tecnici e meccanici.
Questo stabilimento è parte della memoria storica di Gratosoglio. È stato lavoro sicuro per molti, luogo di aggregazione e di ricreazione che ha contribuito alla formazione della zona per come la conosciamo noi oggi.

 Alcune statue della loro produzione sono sopravvissute fino ad oggi.
Alcune statue della loro produzione sono sopravvissute fino ad oggi.
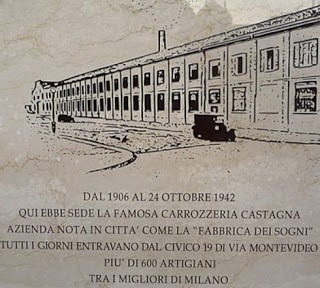










 il primo intervento legislativo del 9 maggio 1929 nota come la "carta del latte". Essa per la prima volta indicava nella pastorizzazione il processo fondamentale per rendere sano e sicuro il latte alimentare. La "carta" sanciva altresì la nascita di un nuovo organismo, la Centrale del Latte comunale, con il compito di ricevere, trattare e distribuire il latte alimentare nei mercati cittadini.
il primo intervento legislativo del 9 maggio 1929 nota come la "carta del latte". Essa per la prima volta indicava nella pastorizzazione il processo fondamentale per rendere sano e sicuro il latte alimentare. La "carta" sanciva altresì la nascita di un nuovo organismo, la Centrale del Latte comunale, con il compito di ricevere, trattare e distribuire il latte alimentare nei mercati cittadini.  Intorno al prodotto si diffondevano le voci più strane, alimentate ad arte soprattutto dai lattai. Si diceva, ad esempio, che la pastorizzazione eliminava le sostanze grasse e riduceva il valore nutritivo dell'alimento e rendeva il latte poco adatto al consumo da parte dei bambini e degli ammalati. Si diffuse addirittura la notizia che il latte pastorizzato veniva trattato con "farine e sostanze chimiche nocive alla salute".
Intorno al prodotto si diffondevano le voci più strane, alimentate ad arte soprattutto dai lattai. Si diceva, ad esempio, che la pastorizzazione eliminava le sostanze grasse e riduceva il valore nutritivo dell'alimento e rendeva il latte poco adatto al consumo da parte dei bambini e degli ammalati. Si diffuse addirittura la notizia che il latte pastorizzato veniva trattato con "farine e sostanze chimiche nocive alla salute". Al tradizionale latte pastorizzato essa affiancava altri tipi di prodotto: il latte omogeneizzato,confezionato nella tradizionale bottiglia a collo largo, zigrinata e chiusa con una capsula di alluminio rosso (da cui il nome "el rùs", cioè "il rosso" in milanese),
Al tradizionale latte pastorizzato essa affiancava altri tipi di prodotto: il latte omogeneizzato,confezionato nella tradizionale bottiglia a collo largo, zigrinata e chiusa con una capsula di alluminio rosso (da cui il nome "el rùs", cioè "il rosso" in milanese), La Centrale dei milanesi. Su questi solide basi si costruiva nei decenni il rapporto tra la Centrale, vera e propria istituzione del latte, e il cittadino milanese. Essa offriva il latte caldo allo stadio, il latte fresco d'estate nei "bar bianchi" al portico Sempione e nei giardini pubblici; vendeva per le strade i suoi prodotti nei "pullman-bar", creati appositamente per "avvicinare la massa dei consuma- tori informandoli sulla importanza del latte"; organizzava annualmente concorsi in tutte le scuole per il miglior tema, poesia o disegno sull'argomento del latte. Dal punto di vista commerciale, questo legame si trasformava in una posizione dominante anche quando i regolamenti del mercato unico europeo imponevano nel 1973 la completa liberalizzazione del settore del latte. La Centrale aveva acquisito e consolidato nel corso del tempo un primato che le aziende concorrenti non sarebbero più riuscite a scalfire
La Centrale dei milanesi. Su questi solide basi si costruiva nei decenni il rapporto tra la Centrale, vera e propria istituzione del latte, e il cittadino milanese. Essa offriva il latte caldo allo stadio, il latte fresco d'estate nei "bar bianchi" al portico Sempione e nei giardini pubblici; vendeva per le strade i suoi prodotti nei "pullman-bar", creati appositamente per "avvicinare la massa dei consuma- tori informandoli sulla importanza del latte"; organizzava annualmente concorsi in tutte le scuole per il miglior tema, poesia o disegno sull'argomento del latte. Dal punto di vista commerciale, questo legame si trasformava in una posizione dominante anche quando i regolamenti del mercato unico europeo imponevano nel 1973 la completa liberalizzazione del settore del latte. La Centrale aveva acquisito e consolidato nel corso del tempo un primato che le aziende concorrenti non sarebbero più riuscite a scalfire
 Nata nel 1927 la “fabbrica del latte” dei milanesi ha sempre avuto come punto di forza il latte fresco e per oltre settant’anni ha svolto l’attività di raccolta, lavorazione e commercializzazione del latte e dei suoi derivati. Ma l’accordo fatto con il Comune di Milano è irrevocabile, per cui 242 dipendenti, 103 automezzi ed i mosaici realizzati da alcune scuole ed artisti milanesi raffiguranti mucche divertite ed al servizio del consumatore, lasceranno la città. Per sempre. Alla fine la Centrale del latte non c'è più.
Nata nel 1927 la “fabbrica del latte” dei milanesi ha sempre avuto come punto di forza il latte fresco e per oltre settant’anni ha svolto l’attività di raccolta, lavorazione e commercializzazione del latte e dei suoi derivati. Ma l’accordo fatto con il Comune di Milano è irrevocabile, per cui 242 dipendenti, 103 automezzi ed i mosaici realizzati da alcune scuole ed artisti milanesi raffiguranti mucche divertite ed al servizio del consumatore, lasceranno la città. Per sempre. Alla fine la Centrale del latte non c'è più.













