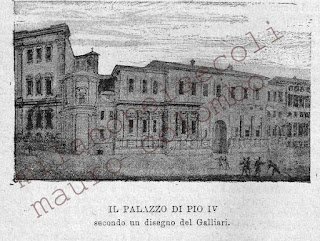Questa è la storia di un angolo di Milano totalmente stravolto e cancellato, un angolo oggi dominato da una serie di edifici costruiti a partire dal 1919, diventati a loro volta iconici e tra le migliori opere
degli architetti che li hanno progettati.
L'incrocio in questione è quello tra le vie, oggi chiamate, via Moscova, largo Donegani, via Turati, via Principe Amedeo e largo Stati Uniti d'America. La via Turati, intorno al quale si è sviluppato tutto il quartiere, è una strada molto recente.Fu infatti aperta, col nome di via Principe Umberto, appositamente per collegare il centro della città con la prima Stazione Centrale che venne inaugurata nel 1864 in Piazza della Repubblica.
La stazione venne infatti realizzata a metà strada tra due porte, Porta Nuova e Porta Venezia; la Milano di allora era infatti ancora chiusa entro i Bastioni Spagnoli.
Per ovviare alla mancanza di un collegamento diretto col centro città venne quindi aperto un varco nel Bastione di Porta Venezia, poi chiamato Porta o Barriera Principe Umberto. Il traforo nei bastioni fu opera del Balzaretto, già impegnato nella sistemazione dei vicini Giardini Pubblici.
Per la sua costruzione vennero fatte arrivare da Bruxelles le colonne in ghisa, realizzate in stile Secondo Impero, a sostegno del sovrastante cavalcavia, in modo di non interrompere il traffico sui soprastanti Bastioni.
Tra gli edifici demoliti per realizzare la nuova strada venne sacrificata la chiesa di San Bartolomeo.
Il curioso tracciato di via Turati, che presenta un angolo molto accentuato all'altezza dell'odierno largo Donegani, è dovuto a problemi di esproprio di terreni da parte del Comune di Milano nel 1860. Non riuscendo quindi a collegare direttamente piazza Cavour con la nuova Stazione Centrale sita in piazza della Repubblica, si decise per un percorso che contemplasse un brusco cambio di direzione, proprio nel punto in cui la nuova strada avrebbe incrociato lo stradone di Sant'Angelo, oggi via Moscova. Quando il nuovo tracciato fu realizzato, correva quasi totalmente tra campi della vicina Caserma di Sant'Angelo e i giardini di Palazzo Melzi d'Eril, che all'epoca si affacciava sulla strada della Cavalchina, oggi via Manin. Alcune delle più ricche famiglie dell'alta borghesia milanese si aggiudicarono alcuni dei lotti lungo il nuovo tracciato ed edificarono alcune splendide ville, con ampi giardini, in quello che presto venne chiamato Quartiere Principe Umberto.
La più bella, senza alcun dubbio, fu Villa Ponti, più nota come Villa Borghi, costruita tra il 1865 sull'angolo nord occidentale dell'odierno Largo Donegani, all'incrocio tra corso Principe Umberto/via Turati e la strada di Sant'Angelo/via Moscova.
Il progetto fu opera di uno dei migliori architetti e ingegneri dell'epoca (nonché matematico), Emilio Alemagna, che la realizzò per la famiglia Ponti, che poco dopo la costruzione la cedette ai fratelli Borghi.
Villa Borghi si presentava come una sorta di casa dai tetti molto spioventi, con rimandi neogotici, con due piani fuori terra e ampi sottotetti abitabili. La villa era arretrata rispetto alla strada, quasi sul margine dell'appezzamento.
L'enorme giardino piantumato, occupava l'isolato tra le odierne vie Turati, Cavalieri, Appiani e Moscova.
Nel 1878 fu realizzato un piccolo edificio a fianco del cancello di ingresso che dava su largo Donegani e l'anno seguente, sempre su progetto di Emilio Alemagna, fu abbattuto e ricostruito realizzando prima un villino di dimensioni più piccole alla villa principale, ma molto simile architettonicamente.
Successivamente l'edificio fu prolungato fino a piegare in via Appiani e a percorrerla per una buona metà.
Durante la Grande Guerra la villa venne utilizzata come Ospedale Militare, accogliendo i feriti che arrivavano con le tradotte alla vicina Stazione Centrale.
L'intero isolato venne venduto nel primo Dopoguerra e la nuova proprietà incaricò lo studio dell’ingegnere Pier Fausto Barelli e dell’architetto Vittorino Colonnese di preparare un progetto per edificare l'intera area.
La due ville furono rapidamente demolite, tra le proteste dei milanesi; il progetto presentato fu però respinto dalla proprietà e lo studio diede mandato ad un giovane architetto assunto poco prima, nel dicembre del 1919, Giovanni Muzio, nato a Milano nel 1893.
Muzio stravolge totalmente il progetto preliminare e realizza quello che poi sarà il manifesto architettonico del movimento artistico chiamato "Novecento".
Quando nei primi mesi del 1922 si smontano i ponteggi e i milanesi possono finalmente vedere il nuovo palazzo, scoppia un pandemonio.
Il palazzo è colossale, enorme, il più alto di Milano con i suoi 7 piani più due altane.
Sino al 1920 infatti le case dentro i Bastioni non potevano superare i 5/4 della larghezza del vicolo o della strada su cui si affacciavano e ulteriori limiti erano previsti a secondo della dimensione della corte interna. Dato che la maglia viaria di Milano era ancora molto stretta in quasi tutta la città, i palazzi erano giocoforza molto bassi.
Al di fuori dei Bastioni vi era invece due leggi che regolamentava le altezze degli edifici. Una non scritta, la Servitù del Resegone, che prevedeva che tutte le case più vicine alla cinta muraria non potessero essere più alte dei bastioni stessi, in modo da non coprire la corona alpina che si doveva vedere da tutta la città; una seconda, ufficiale, fissava il limite massimo di altezza di un palazzo a 24 metri fuori terra, limite raggiunto in quegli anni solo da un edificio, un palazzo di corso Buenos Aires al 76.
Per permettere la costruzione del nuovo palazzo del Muzio, il Consiglio Comunale dovette modificare la legge e permettere la costruzione di edifici di 24 metri anche entro la Cerchia dei Bastioni.
Nel giro di poco tempo i milanesi, che non amavano quell'edificio, iniziarono a chiamarlo "la Cà Brütta", soprannome che divenne poi il nome ufficiale del palazzo! Nelle polemiche si inserì anche il Comune, quando i tecnici si accorsero che le due grandi altane, poste agli angoli degli edifici, erano del tutto abusive e non riportate nel progetto approvato.
Una delle due altane è visibile nella foto qui sopra. In primo piano si vede anche il monumento ad Agostino Bertani, di Vincenzo Vela, inaugurato il 5 maggio 1885, poi spostato in piazza Fratelli Bandiera.
Nel 1923 vennero quindi demolite e la Cà Brütta assunse al forma definitiva. Il progetto del Muzio era comunque realmente all'avanguardia. I terrazzi e la copertura erano trasformati in giardini, il palazzo fu il primo a Milano, e probabilmente in Italia, ad avere dei box sotterranei riservati ai residenti.
 I Moti di Milano del 1898, detti anche Moti del Pane.
I Moti di Milano del 1898, detti anche Moti del Pane.Scontri di piazza, avvenuti tra il 6 e il 9 maggio del '98, tra lavoratori, anarchici, socialisti e i militari guidati dal Generale Bava Beccaris. Sulla sinistra si vede un lampione e la cancellata di Villa Borghi. Sullo sfondo il sottopasso dei Bastioni di Porta Venezia e oltre la prima Stazione Centrale.



















 I Moti di Milano del 1898, detti anche Moti del Pane.
I Moti di Milano del 1898, detti anche Moti del Pane.